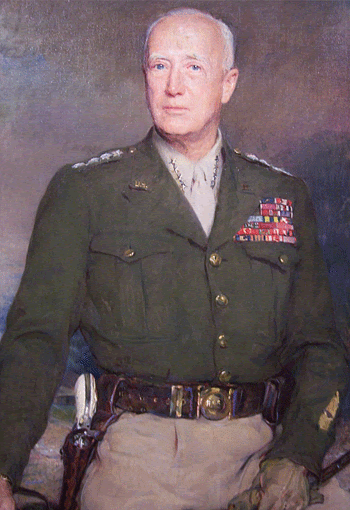Cefalunews, 20
dicembre 2021
Nel primo decennio del
1900 la sola Libia, ultimo lembo dell’Africa mediterranea, rimase incontaminata
da ogni tentativo di ingerenza delle potenze europee. La Gran Bretagna già in precedenza
aveva acquisito il controllo fisico di Cipro, Egitto e del Canale di Suez.
Mentre, la Francia, dopo essersi impadronita della Tunisia e dell’Algeria, in
continuo movimento stava fagocitando anche il territorio del Marocco. In questo
quadro geografico – coloniale, l’Italia, dopo aver assopito i disastrosi eventi
militari di Dogali (1887) e di Adua (1896), riprese, sotto il Governo di
Giovanni Giolitti (1842-1928), le mire espansionistiche verso il continente
antico.

Infatti, restaurate le
finanze interne e rimesse in efficienza le forze armate, l’interesse nazionale
fu rivolto verso la conquista della “Quarta sponda” (ossia le province ottomane
della Tripolitania e della Cirenaica), che avrebbe portato l’Italia oltre a
riacquisire una centralità nel Mediterraneo, rafforzare anche gli interessi
commerciali e finanziari in quei territori. Una sorta di rivincita colonialista
dopo le passate sconfitte in Etiopia.
L’attenzione si sveltì
quando la Francia si assicurò il possesso di fatto del Marocco. Con tutto ciò,
i rapporti di amicizia tra l’Impero osmanico e il Regno d’Italia si
incrinarono, quando […] Il governo Giovine-Turco costituzionale in Turchia –
pel quale furono fatte in Italia tante dimostrazioni di simpatia – si è
mostrato sempre più ostile all’estendersi dell’influenza e della penetrazione
economica dell’Italia nella Tripolitania […] (Cfr. Illustrazione Italiana 5
Novembre 1911).
Questa tensione politica
tra l’Italia e l’Impero Ottomano, come vedremo, sfociò nel conflitto armato. La
violenza nei confronti di cittadini italiani in Cirenaica e Tripolitania fu il
casus belli che portò alla campagna di Libia.
Il giovane Regno sabaudo,
dal canto suo preparò l’azione militare in assoluta segretezza, fin quando
l’incaricato d’affari a Costantinopoli, Giacomo De Martino (1868-1957), il 28
settembre presentò al Gran Visir e Ministro degli Esteri ottomano İbrahim Hakkı
Pascha (1862-1918) un ultimatum (quest’ultimo, il De Martino l’aveva ricevuto
telegraficamente da Roma nella notte tra il 26 e 27).
Per “L’impresa di Libia”
fu costituito uno speciale Corpo di spedizione al comando del Generale Carlo
Caneva (1845-1922), formato da reparti organici: Reggimenti di fanteria,
squadroni, batterie, compagnie del genio, di sanità e sussistenza, in totale,
inizialmente, circa 34.000 uomini (1), e fortemente sostenuto dalla Regia
Marina. Lo sbarco a Tripoli, delle forze italiane, avvenne in due ondate, e
incontrò un’accanita resistenza da parte delle truppe turche e della cavalleria
berbera, tanto che l’Italia dovette incrementare le file del proprio esercito.
Pertanto, la guerra in
terra di Libia non fu una “passeggiata militare” come la stampa nazionalistica
aveva titolato sulle pagine dei giornali, oppure come sovente si era conversato
nei circoli militari. Ciò nonostante, le preliminari brillanti operazioni
navali della nostra Marina furono salutate in Italia da un’ondata di entusiasmo
e ottimismo. Soprattutto per la rischiosa, quanto fulminea operazione navale
dei Dardanelli.
In realtà, sin dagli inizi
della guerra di Libia, la Regia Marina che aveva il completo controllo dei
mari, aveva già predisposto un piano per forzare lo Stretto dei Dardanelli.
Inoltre, tentò più volte di costringere la flotta turca ad affrontare i
combattimenti in mare aperto. Ma gli ottomani avevano sempre evitato lo
scontro, arroccandosi al sicuro, lungo il braccio di mare che collega il mar di
Marmara all’Egeo.
La flotta italiana si era
spinta sino ai litorali ottomani per assicurarsi le basi d’appoggio, e di
conseguenza bloccare la fascia costiera egea. Furono occupate Rodi e le isole
del Dodecaneso, e il tanto desiderato piano militare per forzare l’Ellesponto,
alla fine si concretizzò. Infatti, l’incursione nel Canale dei Dardanelli
(Çanakkale Boğazı), fu affidata al Capitano di Vascello, Enrico Millo
(1865-1930) al comando di 5 torpediniere d’alto mare: Astore, Centauro,
Climene, Perseo e Spica. Proprio sul
silurante Climene era imbarcato il nostro concittadino termitano Agostino Longo
(1889-1967), cannoniere scelto.
«Nella notte tra il 18 e il
19 luglio la formazione si spinse coraggiosamente per circa 11 miglia,
all’interno del braccio di mare, giungendo sino agli sbarramenti di
Costantinopoli. L’intento era quello di colpire con i siluri le grandi e
pesanti navi da guerra nemiche ormeggiate nella rada di Nagara. Ma, una volta
scoperte dalle vedette di sorveglianza ottomana, e nonostante l’incidente allo
Spica, le nostre unità navali elusero gli energici tiri di artiglieria,
invertirono la rotta e si ricongiunsero alle navi di appoggio: l’incrociatore
corazzato Vettor Pisani, e i cacciatorpediniere Nembo e Borea.
L’impresa italiana dei
Dardanelli ebbe un grosso eco internazionale e generò delle ripercussioni in
seno alla politica turca. In realtà, il Governo di Costantinopoli fu costretto a
dimettersi, e si formò un nuovo governo più incline alla pace, guidato da
Kiamil Pascià (1832- 1913).
Nei primi giorni del luglio 1912, il ministro delle Marina
vice ammiraglio Pasquale Leonardi Cuttica, il capo di stato maggiore vice
ammiraglio Carlo Rocca Rey e il responsabile dell’ispettorato siluranti
capitano di vascello Enrico Millo, si riunirono nel massimo segreto presso il
ministero della marina a Roma, per discutere i particolari per il forzamento
dello stretto dei Dardanelli e il siluramento della flotta turca, quella che
sarà una delle più ardite azioni compiute da una marina da guerra.
Lo stato maggiore della marina fin dai primi giorni della
guerra scoppiata improvvisamente il 29 settembre 1911 aveva sempre sostenuto
che per costringere la Turchia alla resa occorreva colpirla al cuore del suo
impero. Ma il governo aveva sempre negato l’autorizzazione in quanto l’impresa
avrebbe inevitabilmente creato problemi diplomatici, ma ore dopo mesi di
guerra, con risultati militari modesti, e i turchi che cercavano dii ritardare
le trattive di pace nella speranza che un intervento delle diplomazie
internazionali a loro favore, l’operazione sembrava l’unica possibilità di
costringere la Turchia alla resa.
Il tutto inizio nel lontano 1881, quando noncurante degli
interessi italiani già presenti in Tunisia, la Francia la occupò militarmente e
la dichiarò suo protettorato, cosa che porto l’Italia ad aderire alla triplice
alleanza con Germania e Austria.
Nel maggio 1911 prendendo come spunto una rivolta contro il
sultano del Marocco la Francia inviò un corpo di spedizione, ma questa volta il
Kaiser Guglielmo II, che aveva anche lui aspirazioni sulla sponda africana del
Mediterraneo, inviò la Cannoniera Phanter
a sostegno del sultano, il fine del kaiser era quello di ottenere una
contropartita territoriale dalla Francia, alla fine i due paesi si accordarono
per l’occupazione della Libia da parte Germania.
Il governo italiano decise di impedire l’inserimento di
un'altra potenza in Tripolitania e Cirenaica, vista la particolare situazione
internazionale favorevole all’Italia, decise per l’invasione della Libia.
Frettolosamente il 26 di settembre il governo emanò le disposizioni per la
mobilitazione dell’esercito, mentre la notte fra il 26 e 27 settembre inviò al
nostro ambasciatore a Costantinopoli l’ultimatum da presentare al governo turco
con scadenza le 14.00 del 29, una vaga risposta del sultano giunse prima della
scadenza dell’ultimatum, ma non ritenendola soddisfacente, l’Italia si
considerò in guerra.
La flotta turca era composta da due corrazzate, 3
incrociatori protetti, 14 cacciatorpediniere e 25 torpediniere, a queste
l’Italia contrapponeva 10 corazzate, 9 incrociatori corazzati,3 incrociatori
protetti, 21 cacciatorpediniere e 40 torpediniere, la superiorità navale
italiana era il valore determinante per il successo della spedizione, solo il
dominio del mare permetteva all’Italia di inviare uomini e materiali con
continuità per la riuscita dell’impresa, preoccupante era il nucleo maggiore
della flotta turca che si trovava nel porto di Beirut, anche se inferiori
avrebbero potuto creare problemi nella delicata fase degli sbarchi, tanto che
quando il 19 settembre le navi lasciarono il porto si creò una certa
apprensione nello stato maggiore della marina finché non fu informato che il 28
di settembre la squadra aveva dato fondo nei Dardanelli. Il 29 settembre il
Duca degli Abruzzi al comando dell’ispettorato delle siluranti, ricevette
l’ordine di sorvegliare la costa albanese per impedire al nemico di uscire in
mare.
Allo scadere dell’ultimatum, i cacciatorpediniere Artigliere e Corazziere
avvistarono e attaccarono due torpediniere turche nei pressi di Prevesa
affondandone una. Il giorno dopo furono intercettati un cacciatorpediniere e
una torpediniera a Igumenizza e dopo
breve combattimento furono affondati tutte e due, l’Austria preoccupata di un
eventuale invasione dell’Albania, protestò immediatamente, tanto che il governo
ordino di cessare le azioni offensive in Adriatico. Nonostante tutto il 5
ottobre unità italiane entrarono a San Giovanni di Medua per ispezionare una
nave neutrale, da terra aprirono il fuoco e le nostre navi risposero
bombardando le posizioni turche.
L’Austria si convinse che l’Italia mirava
anche all’occupazione dell’Albania e inviò una nota dove lamentava l’accaduto e
chiese il rispetto degli accordi pena contromisure militare, ad appoggio della
nota spostò le sue navi da Pola a Durazzo. A questo punto il ministro della
marina ordinò di sospendere tutte le operazioni in Adriatico.
Intanto il 28 settembre prima della scadenza dell’ultimatum
si trovavano davanti a Tripoli 2 corazzate,4 incrociatori, 2 esploratori e 6
cacciatorpediniere, il primo ottobre circa metà della flotta era schierata
davanti alla città, il 3 ottobre dopo aver intimato la resa, la squadra iniziò
il bombardamento dei forti Hamidiè e Sultania posti a difesa della città,
all’alba del 5 le navi sbarcarono una compagnia di 970 uomini che occupò il
forte Sultania e una seconda compagnia di 770 fu fatta sbarcare alle 15.00 che
occupò il porto è l’abitato subito dopo lo sbarco i marinai costituirono una
linea di difesa intorno a Tripoli. Negli stessi giorni compagnie da sbarco
della Marina occuparono Tobruk.
Solo il giorno 13 i marinai furono sostituiti
dai soldati del regio Esercito, tornarono
alle navi ma sempre pronti ad intervenire, dopo poco tutte le principali città
furono occupate, sempre con l’ausilio di compagnie da sbarco della Marina.
Visti i pochi progressi che venivano dal fronte terrestre, il governo informò
l’Austria che avrebbe portato la guerra nell’Egeo, furono così occupate alcune
isole con l’assicurazione che sarebbero state lasciate a conflitto ultimato. Il
5 novembre l’ammiraglio Revel presentò un piano per l’attacco ai dardanelli,
che ripresento il 29 di febbraio, e ricevette l’ordine di procedere verso la
metà di marzo. L’ammiraglio mise a punto tutti i particolari, la parte
principale era affidata a sei torpediniere, mentre una corazzata, 3
incrociatori, un incrociatore ausiliario e due cacciatorpediniere dovevano scortare
le torpediniere, all’ultimo momento si scoprì che i turchi avuto qualche
sentore avevano spostato la flotta nel Mar di Marmara e intensificato la
sorveglianza, un secondo attacco fu tentato la notte fra il 17 e18 aprile,
mentre le unità maggiori si tenevano pronte ad intervenire, le siluranti si
avvicinavano allo stretto, ma il mare mosso impediva di mantenere la formazione
quindi l’operazione venne di nuovo sospesa, la mattina dopo la squadra italiana
tentò di attirare le navi turche fuori dagli stretti, mentre 3 corazzate e 3
incrociatori si tenevano nascosti dietro l’isola di Imbros altri 3 incrociatori
si portarono davanti agli stretti ma non accadde nulla, dopo due ore le navi
rimaste nascoste si avvicinarono ai Dardanelli, da dove stava uscendo un
cacciatorpediniere con compiti esplorativi, i tre incrociatori iniziarono ad
inseguire l’unità turca, che batté in ritirata, quando le unità giunsero a
circa ottomila metri dalla costa i forti ottomani aprirono il fuoco, la navi
italiane risposero, lo scontro durò circa 2 ore, le navi italiani spararono 550
colpi provocando notevoli danni ai forti. A questo punto la Turchia reagì in
maniera pericolosa, chiudendo gli stretti al traffico commerciale, provocando
le vivaci reazioni delle nazioni europee. I Turchi speravano che le diplomazie
avrebbero obbligato l’Italia ad abbandonare l’impresa. Ma il 2 maggio 1912 le
pressioni europee e soprattutto della Russia costrinsero i turchi a riaprire
gli stretti. All’inizio di giugno dopo molte difficoltà si svolsero a Losanna
incontri riservatissimi, ma i turchi dimostrarono di non voler giungere ad un accordo, fu così rispolverata l’idea di
attaccare le navi nei Dardanelli.
Dopo i colloqui al ministero, ai primi di luglio, il CV Millo
lasciò Roma e a bordo dell’incrociatore Vettor
Pisani raggiunse il 12 Stampalia, con la scusa di effettuare lavori
idrografici nelle isole occupate. Quindi si sposto nella baia di Parthana
nell’isola di Lero, dove lo aspettavano 5 delle più recenti torpediniere. Lo Spica della classe Sirio, costruita nei
cantieri Schichau di Elbing ( citta vicino Danzica), varato il 15 luglio del
1905 con un dislocamento di 210 T era armata con tre lancia siluri da 450
mm e tre cannoni da 47mm, la potenza
dell’apparato motore era di 3000 CV e le consentiva di oltrepassare i 25 nodi,
fu radiata il 24 marzo 1923. Le altre 4 Perseo,
Astore, Climene e Centauro appartenevano alla classe
Pegaso di 18 unità. Perseo, Climene e Centauro furono costruite dai cantieri
Pattison di Napoli, L’Astore dai cantieri Orlando di Sestri Levante.
Dislocavano 216.5 T e avevano lo stesso armamento e velocita dello Spica. Il
Perseo fu varato nel dicembre del 1905
ed affondò il 6 febbraio del 1917 nei pressi di Stromboli in seguito a
collisione con L’Astore . L’Astore fu varato nel giugno del 1907 e fu radiato
nel 1923. Il Climene fu varato nel maggio del 1909 e vi fu installata una
caldaia a nafta, mentre quelle delle altre unità erano alimentate a carbone, fu
radiato nel 1926. Il Centauro fu varato nel 1906 e il 5 novembre del 1921 si
arenò nel golfo di Adalia ( Turchia) andando completamente distrutto.
L’operazione fissata per il 16 luglio, fu spostata al 18.
Le torpediniere scortate dal Vettor Pisani e due
cacciatorpediniere lasciarono Lero alle 18.00. a loro sostegno le seguivano a
distanza le Corazzate Vittorio Emanuele, Regina Elena, Roma e Napoli e gli
incrociatori Pisa, Amalfi e San Marco, pronti a intervenire nel caso di un
contrattacco turco. Alle 23.30 dopo che Millo aveva trasbordato sullo Spica le
torpediniere lasciarono la loro scorta ravvicinata e verso mezzanotte alla
velocità di 12 nodi imboccarono i Dardanelli, poco dopo Millo rilevata una
leggere corrente contraria aumentò la velocità a 15 nodi, diversi proiettori
dei forti erano accesi le unità italiane non furono avvistate, verso le 00.40
un proiettore del forte di Capo Helles inquadrò l’Astore seguendolo per alcuni
minuti. Immediatamente venne dato l’allarme e fu aperto il fuoco sulle
torpediniere, alcuni colpi caddero in prossimità delle torpediniere, ritenendo
la difesa fiacca Millo decise di continuare ad avanzare per poi decidere sul da
farsi, i suoi ordini infatti prevedevano che se l’attacco fosse risultato
troppo pericoloso l’azione doveva ridursi ad una semplice ricognizione, quidi
ordino di aumentare la velocità a 20 nodi e si avvicino alla costa europea. Le
unità inquadrate dai proiettori navigavano sotto il fuoco nemico, diversi colpi
perforarono il fumaiolo dello Spica, alcuni colpi di piccolo calibro colpirono
il Perseo nello scafo e in coperta, L’Astore fu colpito due volte nello scafo e
diverse altre alle sovrastrutture, ma continuavano ad addentrarsi nello
stretto, dopo aver percorso circa 11 miglia dall’entrata dello stretto ed a
circa 2 dagli ancoraggi turchi, lo Spica incappo in un ostruzione di cavi
d’acciaio che bloccò l’elica, dato la batteria di Kilid Bar aveva aperto il
fuoco saturando lo spazio libero dalle ostruzioni presso la punta, Millo al
fine di evitare la perdita di vite umane e delle navi, non appena lo Spica fu
libero e le eliche furono di nuovo in moto ordinò alla squadriglia di invertire
la rotta ed uscì dai Dardanelli, anche se l’uscita fu più difficoltosa
dell’entrata, riportando solo lievi danni e nessuna perdita umana.
Il risultato militare dell’azione non fu eclatante ma ebbe
effetti psicologici tremendi, i forti avevano sparato a casaccio senza vedere
ne sapere, le navi erano state sorprese con i fuochi spenti e nonostate
avessero acceso i proiettori non erano riusciti ad individuare le torpediniere
italiane. Il governo turco fu costretto a dimettersi ed il nuovo governo fu più
propenso alla pace che diede un nuovo impulso alle trattive in corso a Losanna,
la pace fu firmata il 18 ottobre del 1912.
Sull’onda dell’impresa, gli inglesi tre anni dopo pensarono
di porte replicare l’azione contro i dardanelli, cosa che non si rilevò facile
e portò all’insuccesso della spedizione di Gallipoli».
Note:
(1)
L’Esercito Italiano Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico.
(2)
Virginio Trucco è nato a Roma, ha frequentato l’Istituto Tecnico Nautico
“Marcantonio Colonna”, conseguendo il Diploma di Aspirante al comando di navi
della Marina Mercantile. Nel 1979,frequenta il corso AUC (Allievo Ufficiale di
Complemento) presso l’Accademia Navale di Livorno, prestando servizio come
Ufficiale dal 1979 al 1981. Già dipendente di Trenitalia S.p.A. lo storico
navale Virginio Trucco è membro dell’Associazione Culturale BETASOM (www.betasom.it).
Bibliografia e sitografia:
Enrico Corradini, Cronache della conquista di Tripoli, Illustrazione Italiana Anno XXXVIII n.
45 – 5 Novembre 1911.
AA.VV. Album ricordo
Dardanelli 18-19 Luglio 1912, Macchi, 1913.
Navi e Marinai D’Italia.
Le grandi battaglie del XX secolo. Storia della Marina.
Paolo Maltese, L’impresa
di Libia, in Storia Illustrata N° 167, ottobre 1971.
Stato Maggiore
dell’Esercito. L’Esercito Italiano, Ufficio Storico. Roma, Dicembre 1982.
Carlo Rinaldi, “I
dirigibili italiani nella campagna di Libia”, Storia Militare N° 18, marzo
1995.
Hall, Richard C. Le
guerre balcaniche, 1912-1913: preludio alla Prima Guerra Mondiale. Routledge,
(2000).
Gian Paolo Ferraioli,
“Politica e diplomazia in Italia tra XIX e XX secolo. Vita di Antonino di San
Giuliano (1852-1914)”, Rubbettino, 2007.
Ferdinando Pedriali,
“Aerei italiani in Libia (1911-1912)” , Storia Militare N°170/novembre 2007.
Alberto Caminiti,
“Gallipoli 1915 – la campagna dei Dardanelli”, Koinè, 2008.
Paul G. Halpern, La
grande guerra nel Mediterraneo. Vol. 1 1914-1916, Editrice Goriziana, 2009.
Giuseppe Longo 2014,
“Verso il Centenario della Prima Guerra Mondiale 1914/2014”, Cefalùnews, 5
febbraio.
Giuseppe Longo 2014, Cento anni fa scoppiava la Prima Guerra Mondiale (1914-2014), Cefalùnews, 28
luglio.
Fabio Gramellini, Storia
della Guerra Italo-Turca (1911-1912), Cartacanta, 2018.
Giuseppe Longo, Conferenza per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, Società Operaia di
Mutuo Soccorso “Paolo Balsamo, Termini Imerese, 24 novembre 2018.
www.marina.difesa.it
www.iwm.org.uk
www.britannica.com
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/home/
www.agenziabozzo.it
Si ringrazia Angelo Casà
dell’Archeoclub d’Italia Himera di Termini Imerese per il materiale fotografico
inerente le Torpediniere d’alto mare Astore, Centauro, Climene, Perseo e Spica.
Si ringrazia la Prof.ssa
Rosa Lo Bianco, Presidente dell’Archeoclub d’Italia Himera, Termini Imerese.
Foto di copertina: R. Nave
“Vettor Pisani” – Torpediniere d’alto mare “Spica” – “Climene”, – “Perseo” –
“Centauro” e “Astore”.
Giuseppe Longo